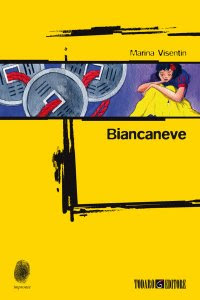Jacques Chessex: L'orco
Sono i primi anni '70, e il fermento culturale che ha scosso i giovani di tutto il mondo sembra essere approdato perfino nella tranquilla Svizzera. Non si tratta certo di una grande rivoluzione; piuttosto di un generico clima d'emancipazione... così, ad esempio, a Losanna, gli studenti delle superiori sono pronti a scendere in piazza per rivendicare diritti misteriosamente negati. A guardarli dall'ombra -un sorriso complice fermo a fior di labbra- il modesto professore di lettere classiche Jean Calmet, non più giovane (almeno non nel senso in cui lo sono gli studenti ai quali va la sua simpatia) ma ancora sospeso in una situazione di adolescenziale indeterminatezza, una mancanza d'identità imposta dall'insormontabile ombra del padre, un uomo appena sepolto, che ha mantenuto, fino all'ultimo, appetiti insaziabili: un padre-orco forse disposto, come Crono, a divorare i suoi figli pur di non essere detronizzato...
In uscita in questi giorni per Fazi Editore, il romanzo “L'orco”, premiato nel 1973 con il prestigioso “Premio Goncourt”, è probabilmente l'opera più "dolente" e “difficile” di Jacques Chessex: dolente perché vi si racconta -in terza persona, attraverso un narratore onnisciente che riporta il punto di vista del protagonista, senza mai assumerlo(2)-, una vicenda dalle ovvie risonanze autobiografiche(3); difficile perché la ricostruzione della problematica identitaria (generata da un rapporto psicologico complesso, conflittuale, patologico, irrisolvibile(4)), e l'evocazione delle sue estreme conseguenze, si fanno strada, nel testo, attraverso un'alternanza di pagine di pura narrazione e attente notazioni ambientali (spesso esteriorizzazione, materializzazione, di stati psicologici), inattese ierofanie, suggestioni autoritarie (la violenza nazista come estrema ratio per l'affermazione del se' e ricorso ad una presunta identità “di razza” sostitutiva rispetto a quella -individuale- mancante) pronte a rovesciarsi in laceranti sensi di colpa, improvvise rivelazioni dionisiache e regresso al mito (esaltazione di un “vitale”(5) naturale che oscilla tra le due polarità di "sottrazione dal" ed "evocazione del" padre(6)).
E la vicenda non si esaurisce nella dimensione familiare: il conflitto tra il mite figlio Calmet e il padre-orco, coinvolge -secondo una suggestione junghiana- l'intero concetto di autorità; il tiepido simpatizzare del professore per i movimenti studenteschi apre, così, la strada, a una rilettura metaforica del '68 e all'anticipazione del suo fallimento su basi morali (scarsa convinzione) e fisiologiche (il passare del tempo che trasforma in "vecchi" i giovani studenti, peraltro già pronti a farsi “padri castigatori” (cfr. p. 113)).
L'essenza del romanzo si realizza, comunque, nella dimensione tragica: in un mondo che ha già conosciuto l'esistenzialismo(7), Jean Calmet è l'eroe (ancora) romantico che, avendo bussato inutilmente alla porta di un dio assente, cieco e muto, e avendo tentato -senza successo- la strada della poesia e quella dell'amore, posto, insomma, di fronte alla totale mancanza di "scelte positive", e all'impossibilità di ogni redenzione, è pronto a scegliere la morte(8), nell'estremo tentativo di sottrarsi al puro dominio del fato.
(1)Jacques Chessex,“L'orco”, Fazi Editore, Roma 2010, p. 176, traduzione di Maurizio Ferrara.
(2)La scelta narrativa, a prima vista piuttosto convenzionale, nasconde in realtà un volontario sdoppiamento “auto-terapeutico”, e uno spostamento del contenuto biografico sul piano finzionale che permette all'autore di dedicarsi a quell'opera di “riscrittura del se'” che è negata al protagonista.
(3)Dalle iniziali J.C., comuni a Jean Calmet e Jacques Chessex (ma anche a Jean Calvin, come fa notare Tommaso Pincio nella sua interessante introduzione all'opera), alla posizione di Calmet, effettivamente professore in un liceo di Losanna nel periodo d'ambientazione del romanzo, e così via fino al tormentato rapporto con il padre.
(4)È l'irrimediabile scomparsa “naturale” del padre-nemico a vanificare ogni sforzo culturale di composizione o risoluzione del conflitto.
(5)Nella determinazione dell'opposizione tra giovanile (e naturale) vitalità e responsabilità, noia e geriatrico ricorso all'autorità, è essenziale l'osservazione del personaggio di Therèse Dubois (o “Du Bois” - letteralmente “del bosco”, secondo un'interpretazione che l'autore stesso suggerisce a più riprese attraverso l'associazione con immagini silvestri, naturali o fantastiche, che vanno dal gatto alla fata, dal latte alla pietra focaia).
(6)Proprio per via di questo secondo polo che evoca l'incontinente esuberanza del genitore, la pura "naturalità" (pre-culturale solo in maniera presunta, in quanto frutto di una scelta) perde ogni valore salvifico.
(7) E, d'altra parte, l'esperienza de "La Nausea" (anche se, più che da Sarte, il personaggio di Jean potrebbe essere stato creato -per problematiche e psicologia- dalla penna di Drieu La Rochelle) sembra affiorare a più riprese.
(8) Ma una morte come "atto" culturale, privo dell'elemento spaventoso, ingiusto (si vedano i brani relativi alla dipartita della giovane studentessa), tipico del "fatto" naturale e incontrollabile.
Labels: 1968, Anni '70, Chessex, Esistenzialismo, Letteratura, Letteratura Francese, Losanna, Mito, Svizzera